Lucy sulla cultura, 31 maggio 2024
Sherif, sull’uscio del ristorante dove lavora nel centro di Roma, sorride e guarda in camera mentre pulisce con maestria un carciofo, spiegando come cucinarlo alla giudia o alla romana. Il video non dura neanche un minuto e viene subito voglia di riguardarlo perché tutta l’operazione sembra di una facilità estrema. Nei commenti qualcuno vuole più informazioni sulla ricetta, c’è chi chiede il modello della lama utilizzata, chi fa notare che non si è mai visto un arabo – Sherif è egiziano – che insegna ai romani a fare i carciofi alla giudia. Il video diventa virale, forse anche per ragioni di indignazione patriottiche.
“L’ho girato per caso”, spiega l’autore, Alessandro Mancini, giornalista e content creator che pubblica brevi video, racconti di luoghi e storie di Roma e di altre città. Ne sta facendo una professione.
Prima del successo di questo video, Sherif aveva già un profilo Instagram, “Er Carciofaro”. “Aveva solo 300 follower e TikTok non ce l’aveva proprio, l’abbiamo aperto insieme. Sherif ha tutte le potenzialità e le caratteristiche per poter diventare un personaggio sui social” racconta Mancini, che, intravedendo del potenziale, ha iniziato a collaborare con lui.
“Sherif è a Roma da almeno 15 anni, ha la cittadinanza italiana, ha una lunga esperienza nella ristorazione e vorrebbe mettersi in proprio. Se riesce ad aumentare la propria visibilità può farcela”, spiega Mancini.
Sempre più spesso le nuove tendenze gastronomiche nascono sui social, lanciate da influencer, foodies e youtuber che scoprono posti e piatti straordinari. Secondo la piattaforma di prenotazioni e recensioni The Fork, il 60% dei consumatori sceglie un ristorante perché si è imbattuto in un video che lo pubblicizza. “La comunicazione conta tantissimo” mi conferma Mancini. “Alcuni posti diventano virali grazie ai social; adesso va tantissimo l’accento romanesco, da quando ha avuto successo il video di una cameriera in un’osteria di Fiumicino. Poi c’è chi si affida ai clienti, sperando che scattino foto dei piatti e del locale… soprattutto i ristoranti più turistici. In questi ultimi si va dagli impiattamenti instagrammabili alle richieste esplicite di una recensione online.
La ricerca della visibilità produce video tutti uguali, ma anche l’offerta gastronomica, che insegue i trend, non è delle più varie. All’inizio, si ricerca la straordinarietà – il panino più alto, il pollo più croccante, la carbonara più cremosa – e si finisce con quartieri che si somigliano tutti tappezzati di ristoranti con tovaglie a quadretti in centro, paninerie, pokerie, sushi bar un po’ ovunque, con un’offerta anche varia ma standardizzata, che si ripete uguale in ogni città. Finché non nasce un nuovo trend, e si ricomincia.
L’omologazione è causata anche dal fatto che le persone cercano quello che hanno già visto. I turisti scelgono i luoghi da visitare in base a un’aspettativa: lo sguardo turistico è una ricerca del già visto, un modo di guardare socialmente costruito, è un grande occhio di massa modellato dall’uso delle immagini. Secondo John Urry, sociologo britannico che ha dedicato al turismo e alla mobilità molti suoi lavori, l’esperienza turistica è essenzialmente di natura visiva, e la nascita di questo sguardo turistico coincide già con la nascita della fotografia. Con l’avvento dei social media, e soprattutto con Instagram, il ruolo delle immagini nel dare forma allo sguardo turistico ha compiuto un enorme salto di scala. La realtà si adegua alle immagini facendosi fondale per i selfie: le panchine giganti nei borghi, le ruote panoramiche, i piatti esposti all’entrata dei ristoranti sono esempi di ‘marker’, segni che per il sociologo Dean MacCannel dovrebbero catturare lo sguardo del turista e che per Marco d’Eramo finiscono per diventare essi stessi attrazioni.
Fino a qualche decennio fa erano perlopiù la stampa e i critici gastronomici a decidere e segnalare cosa valeva la pena visitare e mangiare, ora anche i social orientano la scelta, rendendo questo processo più democratico (o meno professionalizzato). Tutti possono fotografare, dare consigli e tutti possono diventare influencer o almeno ambire a esserlo. E se Urry vede nel turista americano in vacanza a Roma uno dei modi di essere più caratteristici della modernità, emblema di chi ricerca l’unicità oltre l’ordinario, allora capiamo che la logica turistica riguarda tutti, anche i pischelli che fanno la fila in un quartiere periferico per mangiare il panino più alto e il pollo fritto più croccante.
Non basta. “Il nostro bisogno di rassicurazione e autenticità ci spinge a cercare ristoranti che abbiano una storia, chef che trasmettano una filosofia precisa e un tipo di cucina che sia tradizionale e riconoscibile” ci dice ancora The Fork. Il problema è che la ricerca di autenticità e l’ossessione per la tradizione sono nemici dell’innovazione. La proposta non cambia, se non nelle misure: per avere visibilità e funzionare, tutto dev’essere di più – più cremoso, più croccante, più economico – con esiti a volte ai limiti del ridicolo, come i panini di un locale a Centocelle di cui va a caccia un giovane youtuber perchè, ci informa, “sono grossi due volte la mia testa”.
“L’espansione della ristorazione fa parte del cambiamento delle economie urbane basate sempre più sul terziario e sui consumi culturali, anche immateriali e simbolici, ed è uno degli elementi che più sta trasformando le città”.
“Oggi trovare un ristorante dove mangiare bene nel centro di Roma equivale a cercare un ago in un pagliaio” commenta Mancini. Qui la rappresentazione della romanità ha cancellato ogni altra cosa. L’ultima novità, inaugurata da una catena di ristoranti che millanta una storia secolare, è fare la pasta in vetrina, un caso da manuale di messa in scena del backstage turistico I turisti, moderni pellegrini in cerca di autenticità, sbirciano grati dietro le quinte dell’esperienza. Oggi la sfera del consumo è un’esperienza che deve coinvolgere emotivamente le persone: la vendita diventa intrattenimento, l’economia dell’esperienza diventa sempre più immersiva e pervasiva, espandendosi negli spazi della città.
Se la storia del prodotto e del suo territorio di origine è sempre stata parte integrante dell’esperienza finale e quindi del prezzo, oggi sembra assumere sempre più importanza, come l’interesse recente per il vino naturale dimostra: a essere apprezzato non è solo il risultato, ma il metodo produttivo. Questo anche grazie a una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori della necessità che le filiere dell’industria alimentare diventino sostenibili, da un punto di vista ambientale e sociale. Ma spesso la narrazione dell’origine dei prodotti è solo una strategia di marketing. La Bottega Liberati a Roma, per esempio, che tratta solo carne di prima qualità proveniente prevalentemente da allevamenti bradi, a un certo punto ha dovuto pubblicare la lista dei ristoranti che realmente si riforniscono da loro. Secondo lo storico della cucina Guido Farinelli, la maggior parte delle narrazioni sul cibo oggi sono finalizzate a una comunicazione accattivante per un consumo veloce. “Si parla tanto di cibo, ma in maniera superficiale. C’è poca comprensione del lavoro che c’è davvero dietro la preparazione di un piatto, anche in termini di costi. Quello del ristoratore è visto come un lavoro che possono fare tutti, e che promette guadagni immediati. Oltre le banalizzazioni, la realtà è diversa.
L’espansione della ristorazione fa parte del cambiamento delle economie urbane basate sempre più sul terziario e sui consumi culturali, anche immateriali e simbolici, ed è uno degli elementi che più sta trasformando le città. Negli ultimi dieci anni, la crescita della ristorazione in Italia è avvenuta soprattutto nei centri storici, parallelamente al crollo del commercio al dettaglio, ma i ritmi di ricambio delle attività sono altissimi: secondo Confesercenti dopo cinque anni dalla nascita sopravvive solo un ristorante su due.
“La sovrapposizione tra società digitali e società analogiche è un fatto” spiega il sociologo Giovanni Semi, che si occupa dell’evoluzione dei processi urbani. “Esistono due mondi, che però si sovrappongono in alcune circostanze. Le esperienze urbane sono queste circostanze, e tradiscono il fatto che, nonostante tutto, le persone hanno bisogno di dare una forma analogica e incarnata alle proprie relazioni digitali. Quindi, quando il capitalismo digitale e delle piattaforme si espande nel mondo ricreativo e del cibo, poi tende a collassare in attività analogiche: per esempio una cena tra amici che si sono conosciuti sui social, o l’incontro reale tra persone che si sono viste su piattaforme di dating”. Secondo Semi “la città si adatta a questo collasso tra digitale e analogico, fornendo rimandi continui tra un livello e l’altro. Gli effetti sono quelli di un’accelerazione del panorama urbano che si deve adattare a un capitalismo bulimico”. Per questo le attività commerciali nascono e chiudono in poco tempo: “un po’ perché non reggono il livello di concorrenza, anche questa accelerata, e un po’ perché sono di fatto dei temporary shop, ‘negozi temporanei’. Insomma, una città a short-term, a breve termine, lo è sia in termini di consumatori sia di attività che li soddisfano – o meno”.
La short-term city è solo agli inizi, spiega Giovanni Semi. “Siamo sulla soglia di una colossale trasformazione socio-tecnica legata alle intelligenze artificiali, a come queste ridefiniranno il mondo dei servizi, e di conseguenza, l’uso e le funzioni che avranno le città. In questo momento assistiamo a un discreto caos, tra forme tradizionali di ristorazione e grandi innovazioni, come è il caso della logistica legata al cibo preparato”. Secondo Semi è difficile capire se il futuro sarà più aperto e democratico o se, come è però tipico del capitalismo, questa fase di apertura porterà semplicemente i gruppi più forti a “mangiarsi, letteralmente, il mercato. E quindi ad avere pochi provider di cibo globali, con le ramificazioni nazionali e locali” – un progetto simile a quello immaginato dal sistema di fast-food dagli anni Cinquanta in poi, spiega il sociologo. In Italia le catene rappresentano solo il 9% dei ristoranti, rispetto al 60% negli Stati Uniti, ma tra il 2021 e il 2022 hanno fatto un balzo aumentando del 44%, secondo Deloitte. “Sarebbe bello immaginare forme cooperativistiche e digitali prima che arrivino i fondi internazionali a sostenere piattaforme multinazionali. Credo che la sfida stia proprio nell’accettare questo insieme di trasformazioni e socializzarle il prima e meglio possibile”.
La consapevolezza dei rischi legati alla nascita di grandi e piccoli monopoli del cibo non è molto diffusa e a Roma, come in altre città, la ristorazione è uno dei principali settori presi di mira per il riciclaggio di denaro. Ma nel dibattito pubblico il problema dell’instabilità e dell’omologazione dell’offerta gastronomica (soprattutto nei centri urbani) viene spesso posto come un problema di qualità, parola peraltro spesso usata per non dire più costosa. Ma se di qualità si vuole proprio ragionare, allora bisogna chiedersi: perché si apre un ristorante?

Quando Mazzo ha aperto a Centocelle, pochi frequentavano il quartiere popolare, nella periferia più povera e popolosa della capitale, a parte chi andava alle iniziative dello storico centro sociale Forte Prenestino. La trasformazione che aveva investito prima San Lorenzo e poi il Pigneto, con la migrazione verso la periferia di studenti, artisti e giovani famiglie, lì non era ancora arrivata. “Nella zona c’erano due botteghe” ricorda Marco Baccanelli, che insieme a Francesca Barreca organizzava performance e installazioni in cui mischiavano gastronomia, musica e arti visive. I due chef, noti con il nome d’arte The Fooders e prima ancora The Gastronauts, aprirono Mazzo nel 2012 in un locale di 57 metri quadri, proprio a Centocelle. C’erano la cucina e un tavolo sociale per dieci coperti dove si mangiava a turni. “Volevamo aprire a San Lorenzo ma ottenere i permessi era impossibile. Così abbiamo scelto Centocelle, che è il posto dove sono nato, un quartiere tranquillo dove gli affitti erano bassi” spiega Baccanelli. “Eravamo già conosciuti, avevamo un nostro giro ed eravamo stati premiati dal Gambero Rosso”.
Poi a sorpresa è arrivata la recensione del «New York Times». Le richieste di prenotazione sono schizzate alle stelle e le agenzie immobiliari hanno iniziato a riprendere quella recensione, che menzionava Centocelle nel titolo, “tagliando però il nome del ristorante” aggiunge ridendo Baccanelli. Hanno cominciato ad aprire locali e vinerie, osterie, ristoranti. I prezzi erano più bassi che altrove, e si mangiava bene. “Si è diffusa l’idea che aprire un ristorante a Centocelle poteva funzionare e così invece di aprire in centro aprivano lì”.
Le pratiche di consumo che producono innovazione di solito nascono al di fuori di logiche commerciali, a volte da sperimentazioni artistiche. Crescendo, gli artisti e gli chef cercano una sostenibilità economica senza perdere lo spirito dell’inizio. Intanto, però, hanno attirato l’attenzione, hanno illuminato una parte di città, hanno tracciato un solco in cui tutti si infilano. Se dieci anni fa la stampa parlava di ‘rinascita di Centocelle’, oggi il quartiere è ormai saturo di locali. Dopo anni di lavori, a Centocelle ha aperto una nuova linea di metropolitana, sono arrivati gli Airbnb, gli affitti sono aumentati e i ristoranti iniziano a essere frequentati anche dai turisti. “Nel mio quadrante si sfrutta l’immaginario alternativo creato dal Forte Prenestino” racconta Farinelli, che lavora al ristorante ‘Lorto gastronomia contadina’, accanto al centro sociale. Gli attivisti del Forte Prenestino lo sanno e ospitano un ‘Laboratorio di lotte alla gentrificazione’. “Ma c’è anche un’offerta molto più commerciale in altre zone del quartiere. Uno dei locali che ha più successo fa aperitivi con piattini a 4, 5 euro. Affianco, ha aperto un locale con una proposta identica, perché attira i clienti che non trovano posto lì”, prosegue Farinelli. In questa zona, insieme ad altri soci, The Fooders hanno aperto Legs: pollo fritto e birre artigianali. E accanto sono rapidamente comparse delle birrerie che vendono le stesse birre, allo stesso prezzo. “La gente prende il panino da noi e, se non trova posto a sedere, va da loro e compra la birra” racconta Barraca. I processi di omologazione iniziano così, nel solco degli altri, con l’idea di fare soldi facili per emulazione.
Quattro anni fa Mazzo ha chiuso a Centocelle e ha riaperto, sei mesi fa, a San Lorenzo. “La nostra è una cucina semplice, stagionale, con richiami alla regionalità. Però non è vista e rivista, non è banale, tende al classico ma non è tradizionale” spiega Barreca. Nessuna ossessione per la carbonara, l’amatriciana,la matriciana, la cacio e pepe. “Non fare la carbonara è stata una scelta: non ci interessa farle, stare nel mare magnum delle carbocreme di Instagram, non prendiamo parte a quel gioco” afferma Baccanelli. La ‘carbocrema’ è la versione ‘social’ della carbonara, sempre più cremosa, e per questo la pasta viene risottata. “Se proprio devi stare nelle dinamiche social, devi crearne nuove, devi saper dire altro”. Loro sono riusciti a farlo per un motivo molto semplice, ma non scontato: “non nasciamo come ristorante, con una logica commerciale. Nasciamo con la passione per la cucina” spiegano.
“Poi a sorpresa è arrivata la recensione del «New York Times». Le richieste di prenotazione sono schizzate alle stelle e le agenzie immobiliari hanno iniziato a riprendere quella recensione, che menzionava Centocelle nel titolo”.
“Naturalmente quando apri un ristorante non puoi trascurare le dinamiche commerciali. Ma puoi gestirle, crearne altre, non subirle” racconta Baccanelli. “Per anni abbiamo curato noi la comunicazione. In questi quattro anni di pausa dal ristorante, prima di aprire a San Lorenzo, abbiamo deciso di non comparire troppo. Con i reel, le storie, TikTok, siamo in una fase di iper-comunicazione. Può essere positivo sparire per un po’ di tempo, abbassare il volume e riattivarlo quando c’è un motivo per farlo, quando hai qualcosa da dire, Se strilli sempre, dici le stesse cose, a un certo punto non ti ascolta più nessuno” spiega Barreca. La sua bio sul profilo Instagram recita: “Sono qui perché gestisco Mazzo e sarebbe commercialmente inaccettabile non esserci”. Per la riapertura di Mazzo la coppia ha vagliato diverse agenzie di comunicazione, ma nessuna delle proposte li ha convinti. “Non abbiamo capito che direzione sta prendendo la comunicazione, così abbiamo deciso di non farla”.
I due hanno annunciato l’apertura a San Lorenzo postando solo la foto di una sedia su Instagram. Dopo poche ore erano pieni per i primi cinque giorni di attività. The Fooders non guarda quello che fanno gli altri, “per non cadere in competizione”, e non risponde alle recensioni: “se mi devi fare una critica, fammela di persona” dice Barreca.
Certo, le recensioni influenzano la clientela e le piattaforme come The Fork che le ospitano ricattano i ristoratori. Alcuni ristoranti turistici vendono i pasti online e alle fiere internazionali del turismo. “Anche per questo sono sempre pieni. Non vale più la pena faticare per offrire qualità”, mi ha raccontato qualche anno fa il proprietario di uno storico ristorante a Trastevere che ha scelto di chiudere e riaprire in un altro quartiere perché, mi ha spiegato, “quando poi devi combattere anche con assurde recensioni su Tripadvisor è tempo di chiudere”.
Anche in altri quartieri, dove la pressione del turismo e della sfera digitale è minore, i ristoratori temono le recensioni negative dei clienti che hanno prenotato tramite le piattaforme, a volte sopportando pretese esagerate, spiega Farinelli. Uscire da questa logica non è semplice. C’è chi prova a farlo puntando su una clientela locale che tornerà. “Quando metti su un’attività e un ristorante per passione, fa la differenza. Si riflette sulla scelta del personale e in altre cose strategiche, perché questo è innanzitutto un lavoro di accoglienza, le persone lo percepiscono, e in caso tornano” spiega Mauro Lenci, che insieme a Fabio Macrì ha aperto il Bar Bozza a Ostiense, al confine con Garbatella. “Posso avere il prodotto migliore del mondo, ma senza l’atmosfera giusta, non avrei gli stessi risultati”.
Prima di farne una professione, anche Lenci e Macrì organizzavano cene-eventi insieme ad altri due soci. Il quartetto si chiamava Food Fighters e proponeva piatti ricercati a prezzi popolari perché, sosteneva, mangiare bene non dev’essere un lusso. Come i The Fooders, avevano un certo seguito e i due membri che hanno aperto il ristorante lo hanno fatto nel quartiere dove si sentono più a casa. “Alla Garbatella ci sono ancora per lo più ristoranti storici con una clientela di quartiere”, spiega Lenci. A pochi isolati di distanza, in via del Porto Fluviale, i locali aprono e chiudono in continuazione: i prezzi sono troppo alti. “Negli ultimi tre anni a Roma hanno aperto decine di locali, ma quelli che hanno un’anima li posso contare sulle dita di una mano” conclude.
L’apertura di ristoranti che fanno cucina “creativa”, come qualche testata ha definito quella di Mazzo, rende i quartieri popolari più attrattivi per nuovi consumatori e classi sociali diverse da quelle che vi abitano. È l’inizio del più classico dei processi di gentrificazione che tendenzialmente evolve in varie fasi e stadi, e matura con l’arrivo dei capitali da investire nel mercato immobiliare.
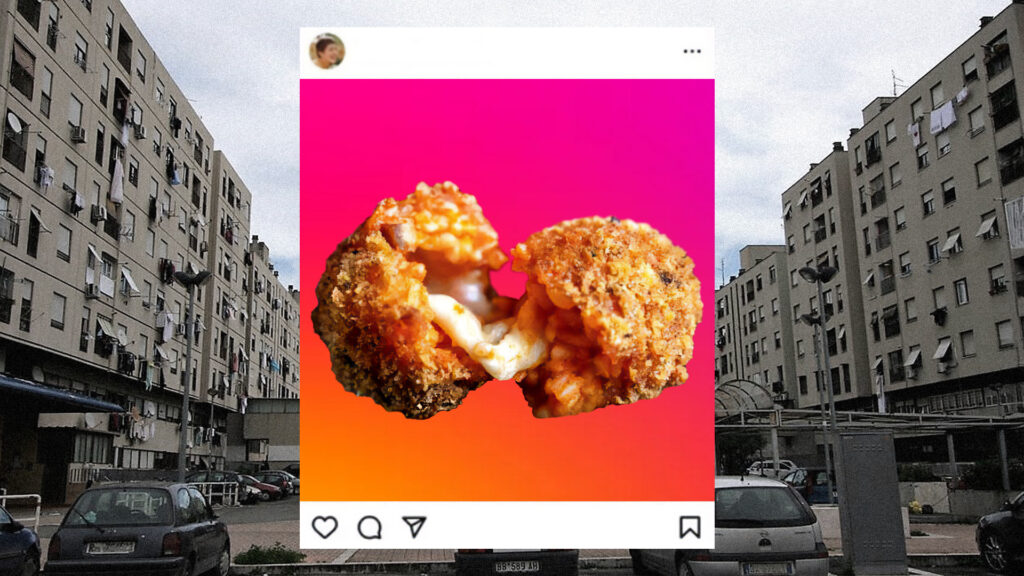
Gli investitori comprano a poco e rivendono a molto, grazie alla trasformazione del valore culturale e simbolico generato da innovatori, in valore al metro quadro. Secondo il geografo David Harvey, il capitalismo ha bisogno delle controculture, ne incoraggia lo sviluppo addirittura, per rinnovare questo processo di cattura del valore. “La qualità della vita urbana è diventata una merce, così come la città stessa, in un mondo in cui il consumismo, il turismo, le industrie culturali e della conoscenza sono diventati aspetti importanti dell’economia politica urbana” scrive il geografo. “La propensione postmoderna a incoraggiare la formazione di nicchie di mercato – sia nelle abitudini di consumo che nelle forme culturali – ammanta l’esperienza urbana contemporanea di un’aura di libertà di scelta, a patto che si abbia il denaro necessario per farlo”.
Il problema non è l’esistenza di ristoranti gourmet, il problema è la scomparsa di tutti gli altri. Il mercato livella tutto e, come l’aumento dei prezzi dopo la pandemia lascia intuire, lo livella economicamente verso l’alto. Mangiare bene da Mazzo oggi non costa molto di più che mangiare male altrove, perché tutti hanno alzato i prezzi. Il problema insomma è l’offerta ‘normale’ che fatica a resistere in un mondo dove il mercato satura ogni spazio alla velocità di un “clic”.