100 parole per l’uguaglianza dei territori
Radici edizioni, maggio 2024
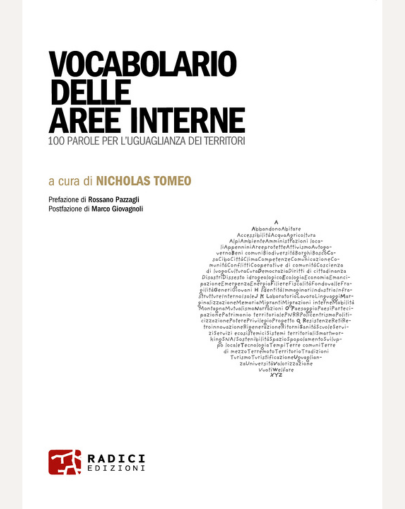
Città
Nell’immaginario consolidato la città è un centro compatto e definito da un confine, distinguibile dalla campagna per densità degli edifici e popolazione. È uno spazio di insediamento e aggregazione di popolazioni, funzioni e servizi, su un territorio dotato di strutture stabili. Ma la città è anche la manifestazione spaziale di processi economici e sociali, dunque quella morfologica è solo una delle sue dimensioni. Nei paesi occidentali, lo sviluppo urbano è avvenuto in stretta connessione con quello industriale per effetto dell’agglomerazione di persone e capitali. A partire dalla fine degli anni Settanta, con la crisi del nesso tra industrializzazione e urbanizzazione, si è assistito a un cambiamento della distribuzione spaziale della popolazione e delle funzioni urbane a una scala metropolitana, con la crescita delle città per ampliamento del raggio di pendolarismo e una diffusione insediativa che – già allora – ha portato alcuni a parlare di ‘morte’ della città e di ‘ritorno alla campagna’. Ma la città non è morta, ha cambiato natura: i suoi confini si sono fatti incerti mentre la mobilità globale di capitali, merci, persone e informazioni aumentava, circolando in una geografia di nodi e poli distribuiti e interconnessi su una scala regionale e globale. Nuovi approcci elaborano nuovi quadri interpretativi dell’urbano – si parla di policentrismo, di urbanizzazione regionale e planetaria; ci si interroga sui limiti amministrativi delle città per delimitare le aree di influenza e la nuova geografia di processi sociali, economici, ambientali in corso mentre, perlopiù, le politiche restano indietro. Più che di forma della città si parla oggi di condizione, di funzioni, di relazioni e processi urbani; più che un luogo, la città è un sistema territoriale. Il modello di sviluppo industriale e poi finanziario che ha fatto delle città i poli della crescita economica e della concentrazione di capitali e di persone ha prodotto profondi divari sociali ed economici dentro e oltre le città. Se i processi di estrazione di rendita si intensificano svuotando di vita i centri urbani, le aree ‘marginali’, impoverite dall’accentramento di risorse e investimenti nelle città sono state, a loro volta, svuotate e dimenticate. Le crisi ricorrenti di varia natura evidenziano la debolezza di questo modello urbano e dell’idea di una crescita incondizionata delle città. Così oggi si guarda con una nuova sensibilità ai ‘margini’ come a luoghi generativi di alternative. E una visione ecologista guarda all’interdipendenza di processi e luoghi, impone il superamento della dicotomia urbano/non-urbano e ribalta, indagando le relazioni territoriali, l’ordine gerarchico tradizionale: sono gli spazi non urbani, con le loro risorse e servizi ecosistemici, a sostenere la crescita delle città. Le città, insomma, non sono autosufficienti: se il processo urbano si materializza all’interno degli spazi cittadini, invariabilmente li eccede, scrive Neil Brenner. Secondo questa visione i paesaggi urbani e non urbani sono dialetticamente co-prodotti nel capitalismo moderno, e dunque la questione urbana può essere decifrata adeguatamente solo attraverso un approccio che li colleghi sistematicamente, in termini sociali, politici, materiali, infrastrutturali ed ecologici.
Brenner, N. and Katsikis, N. (2020), Operational Landscapes: Hinterlands of the Capitalocene. Archit. Design, 90: 22-31
Istituto nazionale di statistica, Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione in italia, ebook, 2017
Lanzani A.S., Pasqui G. (2011), L’Italia al futuro. Città e paesaggi, economie e società. Milano: Franco Angeli
Turistificazione
Con il termine turistificazione si intende innanzitutto la trasformazione dello spazio urbano e naturale a causa dell’aumento dei flussi turistici. Il fenomeno è l’esito di un circolo vizioso fondato sulla convinzione che il turismo generi ricchezza. Città e territori si promuovono come destinazioni turistiche e competono per catturare la spesa dei visitatori, modificando lo spazio in funzione del turismo, per esempio con la costruzione di infrastrutture per popolazioni mobili e temporanee. I luoghi cambiano per assecondare i supposti desideri e gusti di una domanda turistica in parte indotta. Per questo si parla di un effetto di omologazione e perdita di identità dei luoghi turistici – un paradosso, se è vero che alla base della domanda turistica ci sarebbe proprio un’identità locale unica e particolare. Questo avviene perché il marketing urbano e territoriale comporta una ‘messa in scena’ dei luoghi, a partire dalle narrazioni che si usano per raccontarli e che finiscono per modificarli, privatizzarli e mercificarli. Tornando al mantra ‘il turismo genera ricchezza’ sono necessarie due precisazioni: bisogna chiedersi sempre ‘per chi’ il turismo genera ricchezza, e ricordare che la risorsa non è il turismo: la risorsa è il territorio e il turismo è uno strumento di estrazione di ricchezza dal territorio. In questo senso alcuni sostengono che la turistificazione sia a tuti gli effetti una nuova politica coloniale. La collettività che ha storicamente plasmato e che abita questi territori finisce per essere esclusa ed espulsa anche, ma non solo, per l’aumento dei costi che la turistificazione inevitabilmente produce. È dunque un processo dalle profonde implicazioni in termini di giustizia spaziale e sociale. Il turismo è oggi il principale strumento di gentrificazione e di marketing delle città, diventate al tempo stesso imprenditrici e merce di consumo, la risorsa e il prodotto finale, in vendita sul mercato globale. Ma la logica turistica non sta aggredendo solo le città: tutto il territorio gestito come risorsa economica da mettere a valore. Di più, la ‘turistificazione’ non riguarda solo lo spazio fisico: permea le politiche e il nostro modo di conoscere e di fare esperienza della realtà, insomma, il pensiero. La logica turistica separa dall’esperienza quotidiana dei luoghi, isola le ‘attrazioni’ dal loro contesto; semplifica, appiattisce e impoverisce la realtà, è nostalgica, e guarda al passato. Il paesaggio, le città, le piazze sono il costrutto delle nostre azioni sociali, produttive e culturali. Ma per poter essere museificati e venduti, l’illusione turistica deve rompere la nostra relazione con essi: l’esperienza della realtà ci viene negata e rivenduta sotto forma di esperienza turistica. In molte città d’arte, per esempio, lo spazio pubblico è normato in senso securitario e di fatto privatizzato. La sottrazione di spazi toglie la capacità di sentirli nostri, di curarli, di immaginarli, di progettarne il futuro. Se lo spazio pubblico genera cittadinanza, la sua turistificazione ci trasforma in clienti e spettatori: guardiamo il mondo come se non ne facessimo parte, come se il nostro esserci non agisse su di esso, come se non ne fossimo responsabili.
D’Eramo M., Il selfie del mondo, indagine sull’età del turismo, Feltrinelli, 2017
Salerno G. M, Per una critica dell’economia turistica, Venezia tra museificazione e mercificazione, Quodlibet, 2020
Semi G., Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, Il Mulino, 2015